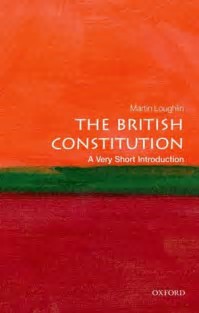 di Fulvio Cortese
di Fulvio Cortese
Come molti ricorderanno, qualche mese dopo il referendum sulla Brexit, la Supreme Court britannica ha deciso che il Governo non avrebbe potuto avviare il processo di uscita dall’Unione europea sulla sola base dei risultati della consultazione diretta: sarebbe stato comunque necessario un voto del Parlamento, in osservanza a uno dei più incrollabili e saldi principi costituzionali d’oltremanica, quello della parliamentary sovereignty. E forse sul Continente più di qualcuno, in quel momento, si è chiesto come sia possibile invocare la sovranità dell’istituzione rappresentativa di fronte ad una delle massime – e inequivoche – espressioni della sovranità popolare. La risposta è semplice: è la British Constitution; niente di più, niente di meno.
Per capirla a fondo, quella costituzione, occorrerebbe risalire alle pagine ricche e avvincenti di François Guizot, che nella Francia della Restaurazione guardava alla storia inglese come all’archetipo più autentico della tradizione costituzionale occidentale. Di un’idea tradizionale di costituzione, non scritta e sedimentata nel tempo, da contrapporre come tale a un’idea moderna, a quella, cioè, che è sorta dall’esperienza statunitense e dalla rivoluzione francese, e che è quella più diffusa, e vigente, anche nel nostro diritto. Certo Guizot aveva una prospettiva molto personale: da critico dei fatti del suo paese, e da conservatore. Ma è vero che lo sviluppo della costituzione britannica è stato a lungo un termine di confronto necessario, sia per evidenziarne i tratti originali, sia per scoprirne il carattere esemplare. Sicché farci i conti è tuttora imprescindibile, magari anche per accorgersi che si tratta di una costituzione in forte trasformazione e che, se nel XIX secolo i giuristi europei vi guardavano con grande ammirazione, oggi sono i giuristi inglesi ad apprezzare e a invocare le virtù di un modello diverso.
Questa è la sensazione, almeno, che si prova leggendo la breve ed efficace introduzione che Martin Loughlin, noto e autorevole giuspubblicista della London School of Economics, ha scritto per i tipi della Oxford University Press: sei agili capitoli per immergersi in un’analisi che non vuole essere soltanto un affresco delle peculiarità della costituzione britannica, e che, anzi, sembra concepita sin dall’inizio come il racconto di una sperimentazione progressiva e mai compiuta.
Nel primo capitolo si cerca di evidenziare le ragioni della diversità britannica, individuate, innanzitutto, nella radicata e diffusa convinzione culturale che una costituzione non possa essere un prodotto artificiale, ma debba essere un coerente e armonioso sviluppo dello spirito nazionale. Di qui deriverebbe la riluttanza ad immaginare, in linea di principio, un’unica costituzione scritta. Nel secondo capitolo, però, l’Autore pare suggerire che la storia della costituzione tradizionale inglese sia stata, in realtà, segnata, quasi paradossalmente, da ripetuti e importanti tentativi di fissazione del suo (di volta in volta…) più vero contenuto (dal tempo dei Normanni al Bill of Rights del 1689; dal magistero di Sir William Blackstone a quello di Albert Venn Dicey; dall’opera di Walter Bagehot alle interpretazioni novecentesche). Nel terzo capitolo, quindi, si comprende che anche l’importanza del ruolo attribuito al Parlamento, via via crescente, deriva da questa fondamentale e ricorrente ricerca di una migliore positivizzazione del diritto, in parallelo ai cambiamenti della forma di Stato, e tanto più dopo l’avvento dello Stato democratico.
Diversamente da quanto si è abituati a pensare, dunque, la scrittura del diritto ha, nella British Constitution, un peso considerevole; dato che si può ulteriormente constatare anche con riguardo alla storia delle articolazioni territoriali della Gran Bretagna (illustrata nel quarto capitolo) o dei processi di affermazione e di rafforzamento delle forme di garanzia dei diritti civili (da ultimo con influenza determinante del diritto sovranazionale e, specialmente, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo: di ciò si riferisce nel quinto capitolo).
Con queste premesse le conclusioni di Loughlin (esposte nel sesto capitolo) sono pressoché scontate: siamo ancora sicuri che il “luogo” prediletto dello “spirito” costituzionale inglese sia quello “non scritto” della “tradizione”? Secondo l’Autore, infatti, l’idea tradizionale di costituzione, a lungo celebrata, si è così tanto alterata dal non essere più in grado di spiegare la reale natura delle istituzioni inglesi; e forse, attualmente, queste istituzioni stanno gradualmente abbracciando la cornice del modello moderno.
Eppure, della British Constitution, un aspetto resta ancora invariato: è ciò che Loughlin definisce il tipico “British manner”, vale a dire un approccio che, pur alimentandosi di un’aspirazione costante al cambiamento, non vuole mai farsi “starting afresh”, ma caratterizzarsi, piuttosto, “in an incremental and pragmatic fashion”. Ecco, in questo sintomatico senso della continuità costituzionale risiede, probabilmente, l’ulteriore lezione che il costituzionalismo inglese può dare al mainstream del costituzionalismo globale (e, così, anche del costituzionalismo italiano…): il tramonto di una costituzione non comporta necessariamente la fine della costituzione.

