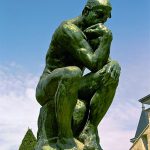 di Glauco Nori
di Glauco Nori
1. Si vuole cambiare la Costituzione: è la maggioranza a volerlo. Tenendo conto delle posizioni contrarie, è probabile che il procedimento fallirà con il referendum confermativo al quale sicuramente si dovrà arrivare. Più che un programma attuabile, sembra una iniziativa velleitaria. È stata proposta con decisione, almeno apparente, senza tenere conto degli sviluppi prevedibili, così da evitare attività e conflitti che risulteranno inutili, ma costosi.
La situazione suggerisce di richiamare alcuni principi, che dovrebbero essere dati per scontati, ma sui quali gran parte dell’opinione pubblica manca di informazione.
Cercare di modificare la Costituzione a colpi di maggioranza è sbagliato in via di principio. La Costituzione regola quegli aspetti della vita e dell’organizzazione pubblica che dovrebbero avere lo stesso rilievo per tutte le parti politiche. Oltre ad alcuni principi fondamentali, sui quali, proprio per essere tali, dovrebbe esserci un consenso generale, vi sono regolati gli strumenti per la gestione della vita dello Stato e gli strumenti di tutela delle minoranze. Con approssimazione, solo per rendere l’idea, si potrebbe dire che quelle costituzionali sono norme che garantiscono le sfere che vanno rispettate da chi si trova ad esercitare i poteri di governo, qualunque sia il suo orientamento. Non si dovrebbe dimenticare che la Costituzione del 1948 riportò il consenso di De Gasperi e Togliatti, in quanto ritenuta utile non solo per la maggioranza del momento, ma per tutti coloro che avrebbero dovuto formare un Governo.
Si obietterà che certi principi sono così scontati da non perdere tempo a ripeterli. Ma se non lo sono più, ripeterli sarà utile non naturalmente per gli esperti, ma per chi si troverà a valutare l’azione dei poteri pubblici in base ai risultati, trascurando i principi.
2. Sono in discussione modifiche costituzionali soprattutto per il premierato e l’autonomia differenziata. Sinora le proposte non sono state articolate a sufficienza. Il solo punto, sul quale sembra ci sia consenso, è che ci vorrà tempo e non saranno realizzate in questa legislatura.
Prima di modificare la Costituzione sarebbe il caso di mettere in chiaro quale è il rapporto tra cittadino e norma, quello che talvolta viene definito come “senso dello Stato”. Spesso si obietta che la domanda, astratta e quasi filosofica, potrebbe disorientare quando si affrontano questioni di rilevo politico, come quelle di ordine costituzionale. Sembra, invece, che anche quando sono coinvolte le norme apicali dell’ordinamento, sia utile domandarsi in quale misura i destinatari siano orientati ad attenersi alle norme formate con l’obiettivo di rendere il sistema più rapido ed efficiente.
Se è prevedibile che una norma sia poco osservata, potrebbe essere il caso di sostituirla con una, tecnicamente meno qualificata, ma che sarà più osservata dai destinatari. La maggioranza che non sarà d’accordo, dovrebbe ricordare che a suo tempo è stato affermato, da chi conosceva la materia, che una norma migliore, se non applicata oltre una certa misura, può risultare meno efficace di una peggiore, ma che sia più osservata.
3. Se ci si guarda intorno, qualche preoccupazione è giustificata.
Al contrario di quanto si potrebbe pensare, sembra utile cominciare dalle norme che realizzano interessi di rilevo minore. Sono quelle che si incontrano nella vita di tutti i giorni e che, proprio per questo, incidono maggiormente sul “senso dello Stato”. Se si affievolisce il loro livello, diventando quasi un’abitudine non tenerne conto, ne risentiranno anche le norme di rango maggiore, non escluso quello costituzionale.
È diventato difficile vedere a piedi uno di quelli che un tempo si chiamavano vigili urbani; quasi tutti circolano in auto, più facile a vedersi e, comunque, destinata ad allontanarsi rapidamente. Il rischio di incappare in qualche sanzione si è, pertanto, ridotto. Come si è detto, basta guardarsi intorno. Nelle curve c’è sempre qualche auto in sosta, spesso da entrambi i lati, cosicché, quando si è a un incrocio, per verificare se qualcuno viene da destra, si deve arrivare a mezza strada.
Sembra che finalmente si provvederà alla disciplina dei monopattini. Non si è ritenuto che rientrino tra le macchine di qualsiasi specie che circolano nelle strade guidate dall’uomo, come sono definiti i veicoli dall’art. 46 cod. strada. Anche per le biciclette sono stati trovati motivi di esenzione. Ciclisti in transito sui marciapiedi si sono giustificati rilevando che stavano andando in senso vietato. In pratica, due violazione di legge produrrebbero una legittimità.
Si percorre un senso vietato se non c’è nessuno che possa rilevarlo. Non si rispettano i limiti di velocità quando le condizioni del traffico lo consentono. Non occorre continuare. Per rendersi conto di quello che sono diventate le strade, basta sommare le infrazioni che possono essere rilevate durante una passeggiata di mezz’ora. Quando è stato fatto rilevare ad un vigile, che si aveva avuto la ventura di incontrare, che il divieto di sosta lungo una strada “esclusi i residenti” equivaleva ad un parcheggio riservato, qualche giorno dopo si è intervenuti eliminando “esclusi i residenti”, che hanno continuato a restare esclusi dalle sanzioni.
Nessuno ha manifestato qualche perplessità sul fatto che siano in commercio libero auto che possono raggiungere velocità superiori ai 250 km/h, quando i limiti sulle strade pubbliche sono di molto inferiori. In pratica, nell’interesse di chi le fabbrica, si consente di mettere sul mercato gli strumenti utili per violare le norme.
4. Si dirà che si è insistito troppo sulla disciplina della circolazione che non è oggi il problema di fondo. Il perché è stato già detto: se tante sono le violazioni per interessi di minore rilievo, non ci si può aspettare che le norme siano osservate quando in gioco sono interessi di ordine superiore.
Non era difficile prevedere quello che sarebbe successo con i superbonus edilizi. Che i primi interventi sarebbero stati sugli immobili di pregio, non poteva essere una sorpresa: le maggiori risorse dei singoli proprietari o dei condomini avrebbero abbreviato i tempi. Non solo prevedibili, ma certe, sarebbero state le truffe, dati i precedenti. Tenuto conto dei costi per lo Stato, si sarebbero dovuti predisporre controlli, non solo formali, che avessero garantito la effettiva esecuzione delle opere prima di ammettere al beneficio.
Si è messa in dubbio la legittimità della norma, che ha rimodulato la detraibilità, per il suo effetto retroattivo. Sarebbe stata quanto meno opportuna una motivazione fondata sul confronto degli interessi coinvolti. La normativa era stata varata sulla base di previsioni, non su fatti accertati, previsioni che sono risultate di molto inferiori alla realtà, tali da incidere sulla stabilità del bilancio. Non si è intervenuti, dunque, sulla stessa situazione presa in considerazione dalla norma originaria, ma su sviluppi di fatto diversi che, se noti, avrebbero comportato sin dall’origine una disciplina diversa. Non è stato, dunque, un ripensamento sulla disciplina, ma una presa d’atto che la situazione reale era ben diversa da quella prevista inizialmente. Quando si provvede per una situazione in via di sviluppo, che poi viene ad emergere in dimensioni diverse da quelle previste, se si vuole ancora parlare di retroattività, andrebbe intesa in senso diverso da quello tradizionale.
5. Ormai è diffuso l’interesse a prospettare certe questioni in termini che facciano presa sull’opinione pubblica non informata. Le concessioni balneari ne sono un esempio. La questione viene posta in termini di diritto comunitario, fidando forse sulla diffidenza di una parte dell’opinione pubblica verso l’Unione Europea. Si elude una prima domanda: se il regime di quelle concessioni sia conforme al diritto nazionale. Le spiagge sono beni demaniali e, secondo l’art.823 c c., non possono formare oggetto di diritti di terzi se non nei modi e nei limiti fissati dalle leggi che li riguardano. È compatibile con questa natura che la loro utilizzazione sia consentita per tempi molto lunghi agli stessi soggetti, escludendo qualsiasi altro concorrente? Finora è stato così, ma non è detto che solo per questo sia conforme alla Costituzione.
A proposito della Costituzione sarebbe il caso di soffermarsi su alcune situazioni, quanto meno anomale. Su alcune nemmeno si discute perché la loro durata ne dimostrerebbe la legittimità; non viene preso in considerazione che la loro durata potrebbe essere motivata dal fatto che, per la natura incidentale della questione di costituzionalità, il singolo non si trova in condizione di proporre un giudizio a tutela di una sua posizione giuridica. Su quelle che insorgono quando vengono proposte modifiche rilevanti, quasi mai si parte dalle discussioni in Assemblea Costituente, quando fu elaborata la norma da modificare.
Certi fenomeni, che si stanno verificando in altri settori, apparentemente di poco significato, non dovrebbero essere trascurati. Alcuni temini vedono modificato il loro significato che hanno avuto nell’uso tradizionale. Oggi gli eventi di natura più diversa “raccontano”; tutto avviene “in qualche modo”; “assolutamente” qualifica ogni affermazione o negazione; alle “virgolette” è stato tolto il livello della scrittura e sono introdotte nel discorso parlato, dimostrando così che si è persa la nozione del senso traslato. Non potrebbero essere il segno di una tendenza verso una ulteriore omogeneizzazione acritica del pensiero?

 di Glauco Nori
di Glauco Nori di Roberto Bin
di Roberto Bin di Enzo Balboni
di Enzo Balboni




