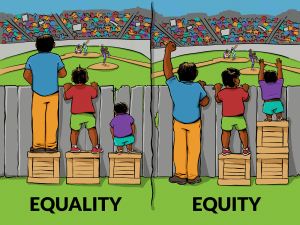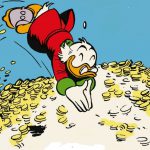Massimo D’Alema non ha certamente bisogno del mio endorsement per poter rappresentare, in caso di suo reingresso, un punto di riferimento, per intelligenza e prestigio politico ed intellettuale, per tante persone che si possano avvicinare di nuovo al Partito Democratico.
Pillole di storia sconosciute o indigeste
Come non essere d’accordo con Miguel Gotor che, sul giornale la Repubblica del 31 dicembre 2022, scrive “Perché l’MSI non fu democrazia”, a chiosa di una affermazione, per mio conto incauta, della Presidente del Consiglio.
La nuova proposta sul debito pubblico: l’occasione perduta per un bilancio europeo
Ad un anno di distanza dal termine del periodo di sospensione del Patto di stabilità e crescita, e a due mesi dalla presentazione della proposta da parte della Commissione del nuovo sistema di regole fiscali (le c.d. fiscal rules) che – per convinzione ampia e diffusa – sarebbe auspicabile adottare dal 2024, le considerazioni e i giudizi che si possono effettuare sono molteplici.
“La verità vera è”: a proposito di legislazione e giudici
Ogni norma andrebbe valutata mettendola in relazione all’ambiente nel quale dovrà operare. Si è adoperato il condizionale perché si ha l’impressione che non sempre ci si curi della corretta individuazione di ciò che si intende disciplinare e dell’attitudine dell’ambiente a rispettare quello che si dispone.
Verso il terzo mandato. I presidenti delle regioni sempre più monarchi assoluti?
Le democrazie sono organismi fragili, da maneggiare con assoluta delicatezza. Vivono di pesi e contrappesi, di bilanciamenti dei poteri per evitare che il venir meno della dialettica o l’indebolirsi della rappresentatività democratica possa rafforzare il potere di un singolo o di gruppi di potere che ne cambierebbero la natura.
Merita il merito?
Dopo l’idea dell’attuale governo di modificare la denominazione del Ministero dell’istruzione in Ministero dell’istruzione e del merito, la questione della meritocrazia sembra tornata prepotentemente alla ribalta. Si tratta di questione complicata, dietro la quale si nascondono formidabili interrogativi pratici.
La pietra d’inciampo: i principi costituzionali sulla tassazione
Colpisce, all’inizio di una legislatura e di un mandato governativo, constatare la centralità che gioca una specifica disposizione costituzionale nel programma e nelle prime decisioni assunte, che proprio perché adottate con tanto senso di urgenza risultano elementi “bandiera”.
Sistema climatico e giudizio di legittimità costituzionale. L’esempio dell’Ecuador
La Sentenza della Corte costituzionale dell’Ecuador n. 1149-19-JP/21 è stata salutata come una delle più innovative e complete decisioni giudiziali in materia ambientale e climatica.
Astensionismo e ipocrisie
In un Topolino di qualche decennio fa, di fronte ai suoi campi allagati da un’improvvisa alluvione, Zio Paperone piangeva con un occhio solo: finché non si sarebbe celebrato il raccolto, i mezzadri non sarebbero stati pagati e le sue monete d’oro non avrebbero lasciato il Deposito.
Perché non possiamo non dirci “biofisici”
Esattamente ottant’anni fa, Benedetto Croce scriveva Perché non possiamo non dirci cristiani: un riferimento ormai classico per riflettere sulla «nuova qualità spirituale» che l’avvento del Cristianesimo ha offerto all’intera umanità, nel bene e nel male.
La riforma dell’art. 41 Cost. davanti al Consiglio di Stato: scelte pubbliche, dati scientifici e transizione ecologica
Una recentissima Sentenza del Consiglio di Stato (la VI sez., n. 8167 del settembre 2022), offre interessanti spunti di riflessione sull’impatto che il riformato art. 41 della Costituzione può produrre sul controllo giudiziale delle scelte pubbliche.
Sentenze suicide nel «Climate Endgame»
La categoria delle sentenze suicide è stata elaborata dalla dottrina giuridica italiana processualistica, penale e civile, nel corso del Novecento (si ricorda il volume di Gennaro Escobedo, Le sentenze suicide, Torino, 1943, con scritti di Antolisei, Calamandrei, Carnelutti, D’Amelio, Vassalli e altri).