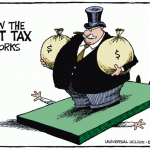L’autonomia, annunciata, evocata e rivendicata fino a diventare una sorta di scioglilingua del discorso pubblico veneto – se si esclude l’accordo sottoscritto da Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna con il governo Gentiloni – sembra destinata a trasformarsi in una ennesima promessa, questa volta di scambio fra i partiti di destra portatori di materialissimi interessi e insediamenti territoriali eterogenei.
“Legislatura costituente”: uso e abuso di una formula vuota
8 settembre 2019, Giuseppe Conte alla Camera dei deputati: “Il mio impegno sarà massimo affinché questa sia una legislatura costituente”; 4 luglio 2018, Fraccaro (M5S) su Twitter: “Sarà una legislatura costituente con l’obiettivo di favorire la partecipazione come mai prima d’ora”; 7 settembre 2017, Giorgetti: “Sì a una legislatura Costituente, no a un governo di larghe intese insieme a chi vuol seguire i diktat dell’Europa”; Matteo Renzi alla Direzione Pd, 13 marzo 2014: “Siamo di fronte a un bivio: procedere con la chiusura della legislatura, attraverso il voto anticipato, o trasformarla in una legislatura costituente”; “Quella che si apre a marzo deve essere una legislatura costituente”, Enrico Letta, Europa, 12 febbraio 2013; Mario Monti: “La prossima dovrà essere una legislatura costituente e per questo occorre una larga maggioranza più ampia di quella che servirà per governare”, La Stampa, 02 gennaio 2013; “La prossima legislatura sarà costituente”, Pierluigi Bersani a Il Sole 24h, 30 ottobre 2012; “Auspico che si cominci a realizzare una legislatura costituente” Renato Schifani (allora Presidente del Senato), 30 luglio 2009; “Ci sono le condizioni per una legislatura costituente”, Gianfranco Fini (allora Presidente della Camera), 29 luglio 2008.
L’emergenza climatica tra “sfera dell’insindacabile” e istituzioni suicide
Un recente Editoriale di questa testata (Pericolo di estinzione umana e interpretazioni giuridiche) invita a discutere lo studio intitolato Climate Endgame: Exploring catastrophic climate change scenarios), dove l’emergenza climatica è descritta come situazione non semplicemente di pericolo bensì ultimativa, distruttiva e finale (appunto un “Endgame”), in quanto la sua posta in gioco è la sopravvivenza delle condizioni di vivibilità di tutti e non semplicemente la lesione, contingente o permanente, di alcuni o molti.
Principio maggioritario, finzioni elettorali e vincolo esterno
Per prescrizione della Costituzione, il fatto che segna la nascita dell’indirizzo politico di maggioranza (nella definizione che ne dà Barile) è il voto di fiducia al nuovo governo.
Fallacie e bias sull’emergenza climatica
di Ines Bruno
Com’è noto, l’emergenza climatica è stata denunciata dalla comunità scientifica internazionale con innumerevoli iniziative e documenti (a partire dai c.d. Scientists’ Warning) e dichiarata ufficialmente da diverse istituzioni, inclusa la UE. Esiste anche una “controdichiarazione” internazionale di negazione dell’emergenza climatica (intitolata There is no climate emergency), promossa anch’essa da un gruppo di scienziati, estremamente minoritario (pari a circa l’1% delle pubblicazioni scientifiche sul tema).
Il senso costituzionale del principio di progressività
Puntuale, in vista della prossima tornata elettorale del 25 settembre, è riapparsa la flat tax, oggi riproposta dalla Lega (al 15%) e da Forza Italia (al 23%).
Elezioni anticipate per salvare i vitalizi dei parlamentari? Sciocchezze
Uno dei temi riemersi a seguito della crisi del Governo Draghi, e del conseguente scioglimento anticipato delle Camere , attiene ad un aspetto del tutto secondario della vita delle istituzioni, ma sempre oggetto di forte attenzione da parte dell’opinione pubblica.
Sulla ineleggibilità dei sindaci che non si dimettono in tempo
Tra le scadenze elettorali collegate al rinnovo delle Camere ve n’è una particolarmente stringente: a norma dell’articolo 7, comma 1, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, i soggetti indicati dalla disposizione citata – tra cui rientrano i sindaci dei comuni con più di ventimila abitanti – qualora intendano candidarsi alla Camera o al Senato devono presentare le dimissioni dalla carica ricoperta almeno centottanta giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, calcolato a partire dalla data della prima riunione delle nuove Camere (art. 7, comma 3).
Gli elettori “fuori sede” possono attendere
La fine anticipata della XVIII legislatura ha definitivamente chiuso ogni spiraglio per vedere finalmente approvata una riforma della legge elettorale volta a introdurre forme alternative al voto in presenza nel giorno delle elezioni.
Già diverse volte tra le pagine di questo blog si è affrontato il tema del voto ai “fuori sede”, coloro che per le più diverse ragioni vivono in un comune diverso da quello nel quale hanno la residenza anagrafica.
In questa legislatura si sono registrati significativi passi avanti, che hanno accresciuto la consapevolezza della politica su un tema così importante. Si pensi al Libro bianco sull’astensionismo elettorale elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero per i rapporti con il Parlamento e presieduta dal prof. Franco Bassanini. In aggiunta, la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aveva ultimamente ripreso a esaminare le diverse proposte volte a introdurre degli strumenti per consentire l’esercizio del voto a distanza.
Il caso vuole che proprio nel giorno in cui si scrive, 25 luglio 2022, la Camera dei deputatiavrebbe iniziato a esaminare predette iniziative legislative, partendo probabilmente da un nuovo testo base, alla cui elaborazione stavano lavorando sia il Ministero per i Rapporti con il Parlamento che il Ministero dell’Interno.
Ebbene, prendiamo atto che in occasione delle elezioni del 25 settembre prossimo, studenti e lavoratori fuori sede dovranno ancora una volta sostenere enormi costi sia in termini economici, che organizzativi per far ritorno nel luogo di residenza, al fine di poter esprimere validamente il proprio suffragio per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Si tratta di ostacoli all’esercizio del voto che sarebbe compito della Repubblica rimuovere al fine garantire l’effettiva partecipazione di tutti i cittadini all’organizzazione politica del Paese (art. 3, comma 2 Cost.).
Il sistema di voto attualmente vigente, oltre ad essere anacronistico è senza dubbio paradossale. Per le prossime elezioni politiche uno studente che si raca all’estero per svolgere un Erasmus potrà votare per corrispondenza; un suo collega che, invece, dopo aver finito gli studi superiori decide di spostarsi in una città universitaria italiana, molto lontana da quella di provenienza, dovrà necessariamente far ritorno nel luogo di residenza per esercitare il proprio voto. Infatti, la legge 6 maggio 2015, n. 52 (cd. Italicum) ha introdotto, tra le altre cose, un una modifica alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, con l’inserimento di un nuovo art. 4-bis. Quest’ultimo, al primo comma, ha esteso il voto postale, già previsto per i nostri connazionali stabilmente all’estero e iscritti all’AIRE, anche agli italiani che si trovino in un altro Paese per “motivi di lavoro, di studio e di cure mediche” per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione. La modifica del 2015 crea un evidente controsenso, viziato forse da irragionevolezza, dal momento che si trattano situazioni uguali (essere elettori in mobilità) in modo diverso. Si ricordi, tra l’altro, che l’art. 48, comma 3, impone al legislatore di garantire l’effettività dell’esercizio del voto (su cui secondo alcuni si può trovare il fondamento per l’ammissibilità del voto per corrispondenza) solo agli elettori italiani residenti all’estero. Orbene, per quanto sia stato giusto estendere tale facilitazione anche a coloro che si trovino temporaneamente all’estero, sarebbe altrettanto giusto, anzi doveroso, prevedere delle agevolazioni – non solo economiche – anche per gli elettori in mobilità sul territorio nazionale.
In conclusione, se, con tutte le differenze tra gli ordinamenti, già durante le elezioni presidenziali statunitensi del 1864 venivano impiegate forme di absentee voting, l’Italia del 2022 dovrà ancora attendere. Tuttavia, il prezzo dell’attesa è molto alto. Ne va dell’effettivo esercizio di un diritto fondamentale, pietra angolare della cittadinanza democratica.
* Dottorando in Discipline giuridiche nell’Università degli Studi «Roma Tre»
Il caso Neubauer e la recente riforma dell’art. 9 Cost.
A marzo del 2021 la Corte costituzionale tedesca (Bundesverfassungsgericht) ha adottato una decisione che per diversi motivi è già entrata nella storia. In questo commento mi propongo di mettere in luce le principali novità, nonché le principali criticità, sollevate dalla decisione.
Unione europea e difesa comune
Nella prima metà del 2000 l’Unione Europea, mentre tentava di adottare una Costituzione, ha dovuto decidere sull’ammissione di Stati che avevano fatto parte dell’Urss: i due adempimenti non erano indipendenti e l’esperienza lo ha confermato.
«Giudizio universale» tra emergenza climatica e “fine” del bilanciamento costituzionale
La causa climatica italiana “Giudizio universale” inizia finalmente a costituire oggetto di approfondimento monografico da parte della dottrina. È un riscontro importante, perché la vicenda è inedita nel panorama dell’esperienza giuridica nazionale e perché l’emergenza climatica ha, ad oggi, appassionato poco o nulla l’opinione dei giuristi del nostro Paese (a differenza dell’inflazionata passione per l’emergenza Covid).